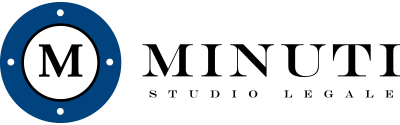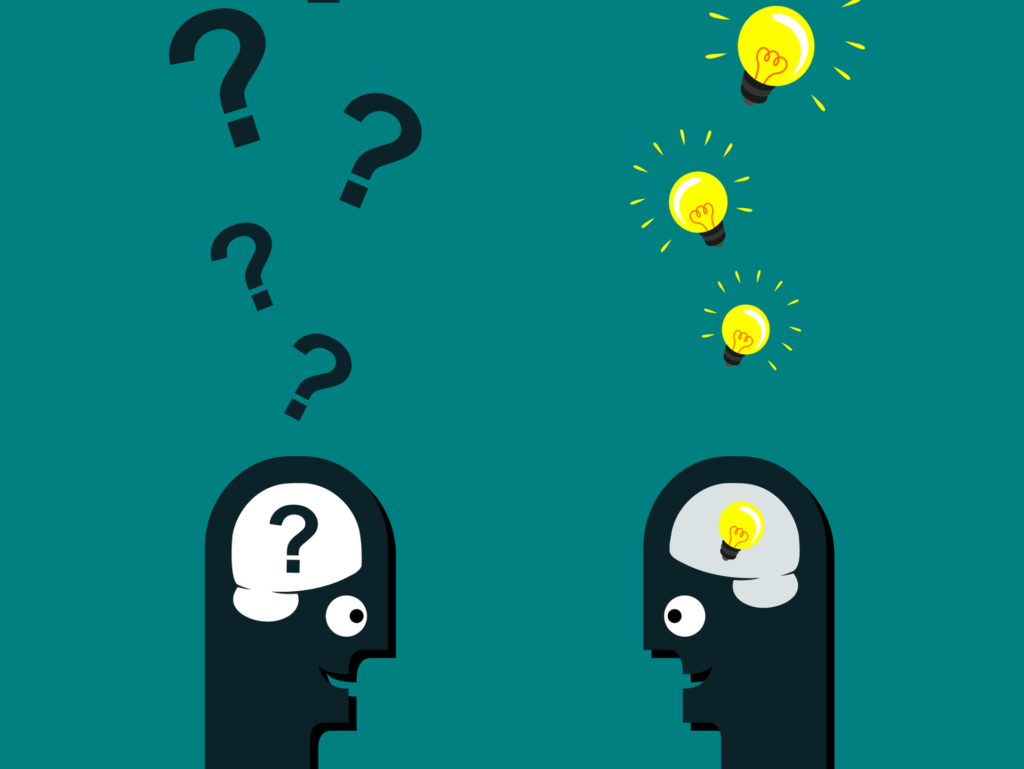È nota l’ ordinanza del 23 aprile 2020 mediante la quale il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha applicato la detenzione domiciliare nei confronti di Pasquale Zagaria, mente economica del clan dei Casalesi, già recluso presso la Casa Circondariale di Sassari, in regime differenziato ai sensi dell’ art. 41-bis dell’ Ordinamento penitenziario.
È appena il caso di ricordare che il cosiddetto “carcere duro” ha la finalità precipua di impedire ai “boss” di comunicare con gli altri detenuti e soprattutto con l’ esterno, così da eliminare i rapporti con le cosche; finalità che il regime carcerario “comune” non consente di raggiungere.
L’ ordinanza succitata ha infiammato l’ opinione pubblica, scatenando una vera e propria “caccia alle streghe”, che ha visto: alcuni, puntare il dito contro il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia), attraverso il quale si sarebbero spalancate le porte delle carceri; altri, stigmatizzare il Tribunale di Sorveglianza; altri ancora, condannare il Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria.
A fronte di tanto clamore, è doveroso analizzare la vicenda in un’ ottica meramente giuridica, in maniera avulsa da condizionamenti politici.
Non si può non partire dalla sentenza Torreggiani del 2013, tramite cui la Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo ha condannato l’ Italia per la violazione dell’ art. 3 CEDU, ufficializzando il grave disfunzionamento del sistema penitenziario italiano e, in particolare, il sovraffollamento delle carceri con assenza delle principali norme igieniche.
La detta pronuncia prendeva piede dalla storia di tre detenuti della Casa Circondariale di Busto Arsizio ed altri quattro della Casa Circondariale di Piacenza, i quali disponevano di uno spazio personale di appena tre metri quadrati a testa.
A tale sentenza, qualificata come “sentenza pilota”, è seguita la riforma dell’ Ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 10 novembre 2018, allo scopo di migliorare la vita detentiva, anche se forse, sarebbe più corretto affermare sia stata offerta maggiore attenzione alle misure alternative alla detenzione in carcere che non ai problemi di spazio i quali, da oltre trent’ anni, affliggono gli istituti penitenziari italiani, non essendo mai stata coltivata una politica edilizia dedicata allo scopo.
Indiscutibilmente la riforma ha dato maggior rilievo e mole d’ intervento alla Magistratura di Sorveglianza e di riflesso al Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria.
La Magistratura di Sorveglianza è così articolata: Magistrato di Sorveglianza, organo monocratico, e Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale.
Ai fini della disamina, è necessario focalizzare l’ attenzione sul Tribunale di Sorveglianza, il quale ha sede presso ciascun distretto di Corte d’ appello ed è composto da due magistrati ordinari di sorveglianza e due esperti in psicologia, psichiatria, servizi sociali o scienze criminalistiche nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Tribunale di Sorveglianza competente, ossia quello del luogo ove è recluso l’ interessato, su istanza del PM, del difensore o dello stesso interessato, nonché d’ ufficio, provvede con ordinanza circa la concessione di misure alternative alla detenzione in carcere.
Il Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), invece, è uno dei quattro Dipartimenti in cui è organizzato il Ministero della Giustizia e segue le direttive e gli ordini del Ministro.
Tale Dipartimento è garante, su scala nazionale, dell’ ordine e della sicurezza all’ interno degli istituti penitenziari oltre che dell’ adeguata esecuzione delle pene.
Il Capo del D.A.P., scelto per prassi in seno alla magistratura, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia.
Il Tribunale di Sorveglianza e il D.A.P. operano, o meglio, dovrebbero operare nel rispetto del “principio di leale cooperazione istituzionale” ribadito più volte dalla Corte costituzionale, secondo cui <<sotto il profilo della leale cooperazione e, in particolare, sotto quello della correttezza nei rapporti reciproci, l’ attività di concertazione deve svolgersi secondo comportamenti coerenti e non contraddittori. Le parti, inoltre, non possono dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura alle altrui posizioni>> (ex multis Corte cost., sent. n. 379/1992).
Tenendo ben chiare le attuate indispensabili premesse, è così possibile esaminare la specifica vicenda: Pasquale Zagaria, rispetto alla quale non si possono confondere precisi parametri di diritto:
PRIMO, l’ art. 123, comma 1 del Decreto Cura Italia prevede che, ai fini di limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus nelle carceri, le pene detentive non superiori a diciotto mesi, anche se costituenti parte residua di maggior pena, siano eseguite, su istanza, presso l’ abitazione del condannato, ovvero in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza.
La disposizione, peraltro, espressamente NON trova applicazione nei confronti di condannati per il delitto di associazione di tipo mafioso;
SECONDO, una circolare D.A.P., datata 21 marzo 2020, invita le Direzioni degli istituti penitenziari a comunicare con solerzia all’ Autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, i nominativi di tutti i detenuti nelle condizioni di salute, ivi specificamente individuate, implicanti un elevato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19 (ad esempio, neoplasie attive o in follow-up);
TERZO, ai sensi dell’ art. 147, comma 1, n. 2) c.p., l’ esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale può essere differita se deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
QUARTO, ai sensi dell’ art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit., il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre il differimento dell’ esecuzione della pena ai sensi dell’ art. 147 c.p., può applicare la detenzione domiciliare, fissando un termine di durata prorogabile.
La scarcerazione di Zagaria, quindi, non è avvenuta per effetto del Decreto Cura Italia, bensì grazie al combinato disposto dell’ art. 147, comma 1, n. 2) c.p. e dell’ art. 47-ter, comma 1-ter ord. penit.
Il “boss”, infatti, è stato segnalato come un “soggetto a rischio” sulla base della predetta circolare D.A.P.; più precisamente, risulta affetto da una forma tumorale aggressiva, che necessita un programma diagnostico-terapeutico improcrastinabile.
Il problema però, attenzione, si è posto in quanto la struttura ospedaliera presso cui era regolarmente seguito è stata qualificata come “Centro Covid-19”; da questo è sorta la necessità, come emerso dal documento trasmesso ai giudici sassaresi dal Direttore del presidio ospedaliero di Sassari, di trasferirlo presso un istituto penitenziario dove potesse continuare in piena sicurezza il trattamento sanitario.
Il Tribunale di Sorveglianza ha dapprima verificato la praticabilità di un trasferimento presso la Casa Circondariale di Cagliari ricevendo, tuttavia, risposta negativa; in secondo luogo, si è rivolto al D.A.P. affinché verificasse la praticabilità di un trasferimento presso un qualsiasi altro istituto penitenziario attrezzato o, quantomeno, contiguo ad una struttura ospedaliera sicura.
Ebbene, nel silenzio del D.A.P. e con lo scorrere del tempo – la richiesta al Dipartimento risaliva al 4 aprile – i giudici sassaresi, il 23 aprile 2020, si sono trovati costretti ad operare una scelta cruciale: lasciare Zagaria senza cure all’ interno del carcere, rispettando così la ratio dell’ art. 41-bis ord. penit., ma mettendone a rischio la salute e sottoponendolo ad un trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità; ovvero disporre il differimento dell’ esecuzione della pena applicando, quindi, la detenzione domiciliare che, tuttavia, non assicura quella neutralizzazione della pericolosità sociale del condannato garantita dal “carcere duro”.
Ebbene, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto il differimento dell’ esecuzione della pena applicando, per un periodo pari a cinque mesi, la detenzione domiciliare presso l’ abitazione della moglie, a Brescia.
Una scelta coerente, peraltro, con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui <<ai fini dell’ accoglimento di un’ istanza di differimento facoltativo dell’ esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ex art. 147, comma 1, n. 2) c.p., non è necessaria un’ incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l’ infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio al diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario>> (così, da ultimo, Cass., Sez. I, 17 maggio 2019, n. 27352).
Tale orientamento appare conforme ad un’ interpretazione costituzionalmente orientata dell’ art. 147, comma 1, n. 2) c.p., volta a mettere in luce l’ inderogabilità del diritto alla salute, tutelato dall’ art. 32, comma 1 Cost., così come già sottolineato dalla CEDU.
Nondimeno, nel caso di specie, il giusto contemperamento delle esigenze contrapposte sarebbe stato possibile attraverso la prosecuzione dell’ iter diagnostico-terapeutico presso un istituto penitenziario attrezzato (ad esempio, quello di Viterbo) o, quantomeno, contiguo ad una struttura ospedaliera sicura. Se tale soluzione è risultata impraticabile, non è certo per “colpa” dei giudici sassaresi; bensì per la superficialità del D.A.P. che, non solo, ha omesso di rispondere al Tribunale di Sorveglianza in tempi utili ma, nel momento in cui si è palesata l’ emergenza sanitaria, non ha pianificato ex ante l’ eventuale trasferimento di quei condannati sottoposti a regime differenziato.
La storia continua ed infatti, a dimostrazione che qualcosa non ha funzionato, il Ministro della Giustizia, prima ha dovuto giustificare/sopportare le dimissioni del Capo del D.A.P. – dott. Basentini –, poi, quasi in accoglimento del “clamore” suscitato, ha promosso l’ emanazione, da ultimo, del D.L. 10 maggio 2020, n. 29, che impone di rivalutare molteplici scarcerazioni avvenute al pari di quella di Zagaria.
E così, alla luce delle novità emanate, il D.A.P. ha comunicato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari la disponibilità di un posto nell’ istituto penitenziario di Viterbo, conseguentemente i giudici sassaresi hanno fissato, per il 22 maggio, specifica udienza atta a rivalutare la scarcerazione di Zagaria.
Alcune note conclusive:
Indubbiamente nei contatti obbligatori collaborativi tra magistratura sassarese e D.A.P. qualcosa non ha funzionato; il silenzio del D.A.P. è risultato assordante ed inspiegabile, magari la soluzione non cambiava, per assenza di “posti”, ma certamente il funzionamento dell’ amministrazione ha lasciato un segno negativo; è per così dire nell’ aria che molti “boss”, tra cui appunto Zagaria, a breve tempo rientreranno in carcere; risulta alquanto ironico che un “boss”, per motivi di salute, motivi divenuti ancora più rilevanti a causa del Covid-19, si sia ritrovato ai domiciliari a Brescia che è l’ epicentro del “virus”, ossia la città più a rischio di tutta la Nazione; è certamente singolare che molti “boss” – che in quanto tali sono pericolosi e non dovrebbero avere la possibilità di diramare ordini agli affiliati –, di fatto, per circa un mese abbiano potuto avere tranquilli e facili contatti con altre persone secondo “diritto”.
Giova ripeterlo, qualcosa stride; l’ Italia è il “Paese del diritto”, ma è anche il luogo dove le riforme si accavallano e non sono mai radicali; certamente il sistema edilizio carcerario non è al passo con i tempi, tutte le manchevolezze delle strutture, generano, al fine di metterci una pezza, situazioni anomale come quella del “boss” Zagaria; senza entrare in valutazioni politiche, prima il Ministro ha difeso l’ operato del D.A.P., poi, in perfetta contraddizione, ha emanato il recentissimo Decreto Legge.