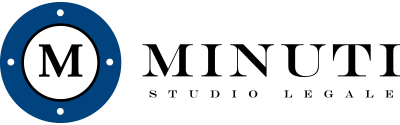1) Buona fede e Lealtà contrattuale
Nella disciplina del contratto per buona fede si intende il fondamentale principio di reciproca lealtà e correttezza al quale tutte le parti del rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi.
La buona fede contrattuale è uno strumento che integra, limita e corregge il contenuto normativo dell’obbligazione. Inoltre, la buona fede, secondo quanto stabilito dall’art. 1366 c.c., assurge a criterio di interpretazione del contratto stesso. La buona fede non impone un comportamento prestabilito, ma richiede comportamenti diversi, adeguati alle concrete circostanze. Essa costituisce, quindi, un precetto rivolto ai singoli in qualità di regola di comportamento e al giudice in quanto modello di decisione, finalizzato a garantire il giusto equilibrio tra interessi opposti.
Secondo il Codice Civile, le parti contraenti devono comportarsi secondo buona fede in ogni fase del rapporto contrattuale, ed in particolare:
- durante le trattative (art.1337 c.c.);
- in pendenza di condizione sospensiva o risolutiva (art. 1358 c.c.);
- nell’esercizio dell’eccezione di inadempimento (art. 1360 c.c.);
- nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).
La buona fede contrattuale, in sostanza, viene oggi intesa come limite generale all’autonomia dei privati, nonché come fonte di integrazione del contratto e come strumento di controllo del suo contenuto.
2) Adempimento ed inadempimento
Adempimento significa l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto; ne conseguono: l’estinzione dell’obbligazione, la liberazione del debitore e la soddisfazione dell’interesse del creditore.
Nei contratti sinallagmatici, caratterizzati cioè dal nesso di interdipendenza tra le opposte prestazioni, a fronte dell’inadempimento di controparte, ciascun contraente può difendersi in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (salvo che tale rifiuto sia contrario a buona fede o le prestazioni non siano dovute simultaneamente), ovvero in via di azione ai sensi dell’art. 1453 c.c., richiedendo l’adempimento contrattuale, oppure la risoluzione oltre al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. L’inadempimento può essere totale o parziale (adempimento non corrispondente a quanto pattuito) e il debitore è responsabile anche in caso di apprezzabile ritardo. La scelta tra adempimento del contratto o sua risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente.
In caso di inadempimento, la parte adempiente può: insistere per l’adempimento, oppure chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Nel caso in cui si chieda la risoluzione del contratto, non si può pretendere successivamente l’adempimento.
Al riguardo non si deve però dimenticare altro principio generale previsto dall’art. 1455 C.C. secondo cui : il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse dell’altra parte.
Sul concetto di adempimento nella tematica del contratto d’appalto interessante la pronuncia Cass. Civ. 5 settembre 2019 n 22152, con la quale si afferma che “in caso di inesatto adempimento della prestazione commissionata, grava sull’appaltatore sia l’onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, sia l’onere di provare che il risultato della stessa, non rispondente a quello convenuto, è dipeso da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alla propria condotta conforme alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alla diligenza qualificata, dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto”.
3) La diffida ad adempiere
La diffida ad adempiere è regolata dall’articolo 1454 del Codice Civile: “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto“.
Chi ricorre alla diffida ad adempiere deve assegnare all’altra parte un termine congruo, decorso il quale il contratto si intenderà risolto di diritto. Come regola generale il termine non deve essere inferiore ai quindici giorni. Resta tuttavia ferma possibilità per le parti di stabilire un termine minore.
La diffida ad adempiere è un atto che deve palesare anche la volontà di sciogliere il contratto se l’altra parte non adempie nel termine assegnato; perciò si deve ben distinguere la diffida ad adempiere dalla messa in mora.
Quest’ultima, infatti, prevede la fissazione di un termine per l’adempimento, decorso inutilmente il quale lo scrivente ricorrerà alle vie legali per veder tutelati i propri interessi. La conseguenza del persistente inadempimento non è quindi la risoluzione del contratto ma il ricorso alla giustizia.
La diffida ad adempiere deve essere inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere nello specifico:
1) l’intimazione ad adempiere;
2) l’indicazione di un termine adeguato (minimo 15 giorni);
3) la dichiarazione che il contratto si intende risolto in caso di inadempimento.
In particolare, Cass. Civ. 10 settembre 2019, n° 22542 ha statuito che:
“in tema di diffida ad adempiere, l’unico onere che, ai sensi dell’art. 1454 c.c. grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l’altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l’avvertimento espresso che nell’eventualità in cui l’adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento (…)”