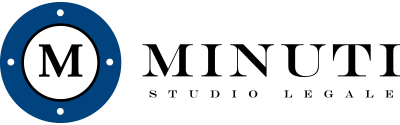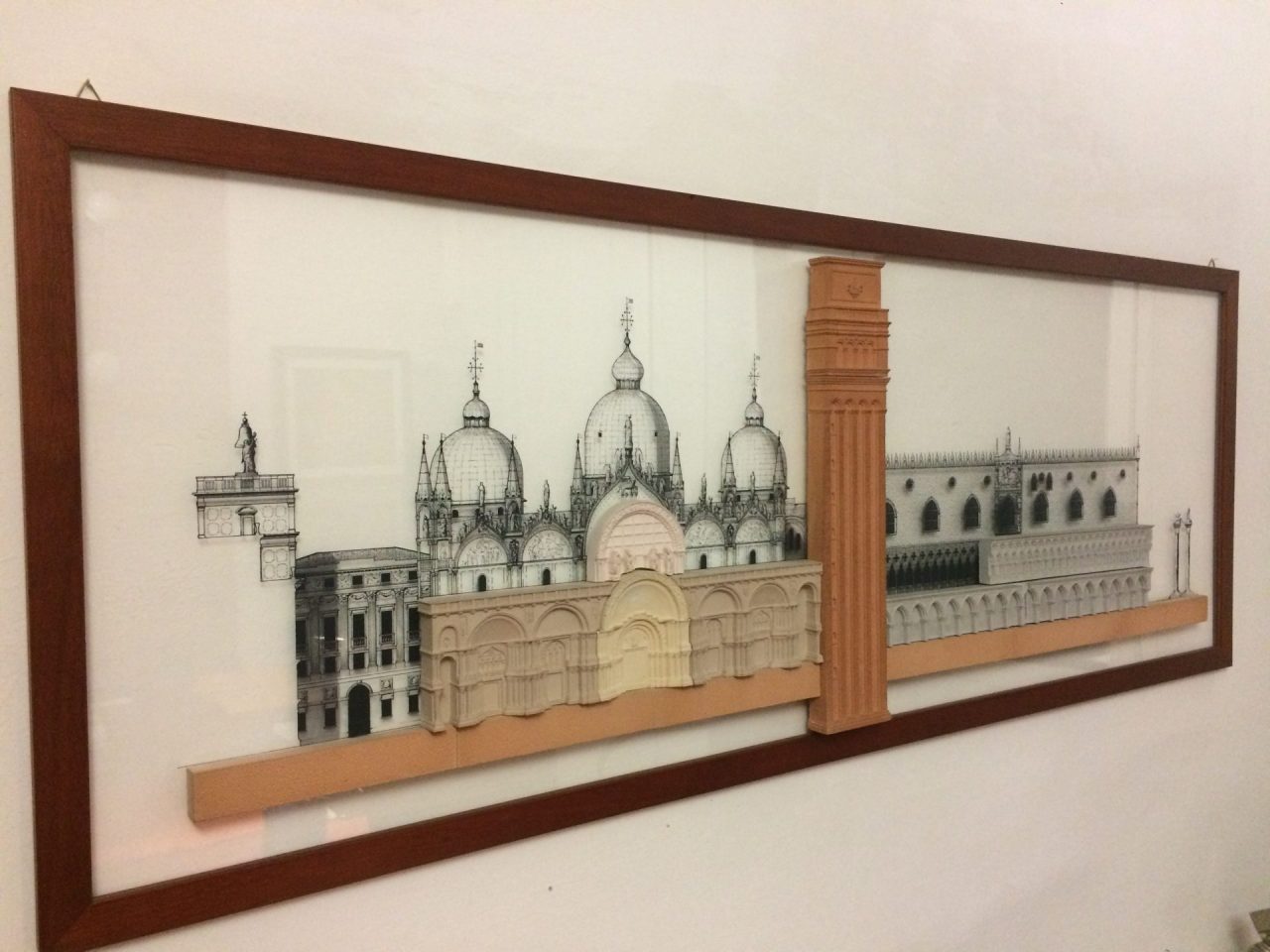Genitori anziani e responsabilita’ legali: la tumultuosa angoscia dei figli
INTERVISTA ALL’AVV. MASSIMO MINUTI – Patrocinante in Cassazione
A cura di DANIELA CAVALLINI
Daniela Cavallini:
La tutela a favore dell’anziano è un tema decisamente complesso poichè pone in contrasto
responsabilità legali con problemi economici e, soprattutto, affettivi. Se per il lato affettivo,
ognuno agisce secondo coscienza, non è possibile sostenere l’identico criterio di soggettività nei
confronti degli obblighi di Legge, quindi è il caso di fare chiarezza…
Avv. Massimo Minuti:
Il nostro Ordinamento non ha una norma specifica dedicata all’anziano; la detta tutela deriva dagli
articoli 591 Cod .Penale e l’art 433 Cod. Civile. che regolamentano anche altre situazioni, non
soltanto lo status di anziano.
L’art. 591 c.p. ( abbandono di persone minori ed incapaci) sancisce un obbligo giuridico di prestare
le cure e l’assistenza all’anziano che per vecchiaia non sia in grado di provvedere a se stesso; tale
omissione prevede una pena che parte da un minimo di sei mesi per arrivare ad un massimo di
cinque anni.
In concreto l’anziano non deve essere in grado di provvedere a sé stesso; i familiari tenuti alla cura e
all’assistenza sono: il coniuge, i figli o comunque i parenti più prossimi; ma, attenzione, l’essere
“povero” per esempio non integra la fattispecie; quello che rileva è il non aver autonomia; non
essere in grado di capire, non essere in grado di curarsi.
L’art. 433 c.c. ( persone obbligate agli alimenti ) invece stabilisce che l’anziano che si trova in stato
di bisogno ha diritto agli alimenti; le persone obbligate sono, nell’ordine: 1) il coniuge, 2) i figli ed
in loro mancanza i discendenti, 3) i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, 4) i generi e
le nuore, 5) suocero e suocera, 6) fratelli germani o unilaterali; ciascuno contribuisce in base alla
proprie condizioni economiche. E’ una vera e propria graduatoria gerarchica; se esiste il coniuge Lui
deve provvedere; solo in assenza del coniuge si passa ai figli e così via; peraltro gli alimenti integrano
una soglia ben al di sotto di un potenziale mantenimento; tanto per intenderci gli alimenti possono
essere quantificati contenuti in modesti euro 250, 00 mensili, mentre un mantenimento offrirebbe
soglie certamente più elevate
Siamo perciò di fronte ad una norma penale ed una norma civile con parametri ed effetti molto
diversi tra loro; nella vita bisogna però essere pratici , quindi bene non scordare che in un processo
penale si ha una sentenza di primo grado dopo quattro anni ( che poi peraltro può essere
impugnata); mentre l’obbligo di natura civilistica ha effetti più immediati, si ottiene nell’arco di sei
mesi; conseguentemente , sia scusata la freddezza , l‘anziano rispetto alla Tutela penale farebbe in
tempo a morire!
Daniela Cavallini:
Qualora vi fosse indisponibilità o impossibilità ai citati adempimenti legali da parte delle figure
designate, queste, in quali rischi incorrono?
Avv. Massimo Minuti:
Innanzitutto si deve distinguere in quale condizione si trovino i destinatari di tali norme, perché, un
conto è sottrarsi e non rivelarsi disponibili, ben altra cosa se, coloro che sono tenuti ad intervenire
abbiano, a loro volta , delle oggettive difficoltà.
L’ indisponibilità dei soggetti tenuti a preoccuparsi può configurare una denuncia per abbandono di
incapace e può determinare l’emanazione di un decreto che ordinerà ai medesimi di contribuire in
termini economici; per contro se vi è impossibilità ( intesa come oggettivi problemi ) sussiste solo
e semplicemente la rete di assistenza sociale e nessun obbligo giuridico .
Senza voler declassare le norme , è ben evidente che ognuno risponde alla propria coscienza, ma in
una situazione di disagio, risulta fondamentale la rete sociale ovvero l’effettivo funzionamento dei
Servizi Sociali.
Se uno pensa ai problemi del settore “casa” le risposte sono immediate ed assimilabili.
Tali Servizi, infatti e purtroppo, funzionano molto diversamente a seconda della Regione di
residenza; l‘Italia non è tutta eguale e la tutela della Salute che ha rango costituzionale, non è
applicata con la stessa qualità in tutto il Territorio nazionale .
Indiscutibilmente le Regioni che offrono maggiore attenzione all’anziano sono il Trentino Alto Adige e
la Toscana.
Daniela Cavallini:
Rispetto all’anziano siamo sempre più abituati a sentir pronunciare i termini “Amministratore di
Sostegno”, “Tutore” e “Curatore”: professionalità che, seppur distinte, possono generare nei cd
“non addetti ai lavori”, confusione di ruoli. In buona sostanza, “chi fa cosa”?
Avv. Massimo Minuti:
L’amministrazione di sostegno è un istituto del nostro Ordinamento che agisce un gradino al
disotto dell’interdizione e dell’inabilitazione; è uno strumento molto duttile, che si adatta a
molteplici casi diversi tra Loro. Si potrebbe definire come una sorta di “stampella” che aiuta il
soggetto ; indistintamente che questo sia giovane o anziano . E’ uno strumento a tutela degli
anziani , ma anche di persone molto più giovani , portatrici di handicap oppure che hanno
qualche lieve ritardo evolutivo ( si pensi alle forme di autismo ), oppure si pensi a quelle persone (
e sono molte!) dedite al gioco che dilapidano i loro beni e non sono in grado di gestire il
patrimonio.
Insistendo in una metafora l’istituto è una “stampella” ma anche un “paraurti” al soggetto
beneficiario/controllato, che necessita di “aiuto” nel suo vivere quotidiano; ma, per ben
comprendere la figura dell’amministratore di Sostegno, detto A. D. S. si devono avere chiari i
punti fermi dell’interdizione ed dell’inabilitazione.
L’interdizione giudiziale è la dichiarata di incapacità di agire della persona maggiorenne che a causa
della sua abituale infermità di mente non è in grado di provvedere ai propri interessi, si ha la perdita
della capacità d’agire e la nomina di un tutore quale Suo rappresentante legale; le condizioni
mentali del soggetto sono stabilmente alterate . Quindi il soggetto non è in grado di provvedere ai
propri interessi; il soggetto, da un lato, diventando maggiorenne, dovrebbe acquisire la capacità di
agire, ma, di fatto, tale “progresso” è bloccato; gli atti negoziali sono pertanto compiuti in nome e
per conto dell’interdetto dal tutore, il quale ne amministra i beni ed ha la cura della sua persona.
Il tutore nei dieci giorni successivi alla nomina deve procedere all’inventario dei beni e nel contempo
deve avere l’autorizzazione del Giudice tutelare per : a) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari
per l’uso del minore, per l’economia domestica; b) riscuotere capitali, c) accettare eredità o
rinunciarvi ; cosi come deve munirsi di autorizzazione per alienare beni, costituire pegni o ipoteche.
L’interdizione legale è, invece , lo stato di incapacità della persona dichiarata con Sentenza penale
tramite la quale la stessa persona è condannata per delitto non colposo alla reclusione per un
tempo non inferiore a 5 anni . Essa ha una funzione sanzionatoria, non è basata, come ben intuibile,
su problemi psichici , ma egualmente si arriva alla nomina del tutore, al pari dell’interdizione
giudiziale .
L’inabilitazione viene dichiarata quando la persona non sia in grado di provvedere ai propri
interessi ed è inferma di mente ma ad un livello non così grave da determinare l’interdizione .
Possono essere inabilitati anche coloro che per prodigalità o abuso abituale di alcolici o altro,
esponga il soggetto o la sua famiglia, ad un grave pregiudizio economico.
Possono essere inabilitati anche il sordomuto od il non vedente dalla nascita. Il sordomutismo e la
cecità dalla nascita sono causa di inabilitazione quando il soggetto non abbia ricevuto un’educazione
sufficiente che gli permetta di provvedere autonomamente ai propri affari.
Esposte le linee guida dell’interdizione, , si comprende che l’inabilitazione è un gradino al disotto ,
ma l’elemento caratteristico comune è l’infermità mentale ; poi si discende in uno spazio più ampio
più duttile ovvero all’amministrazione di sostegno; in altri termini, una volta esistevano
l’interdizione e l’inabilitazione, dal 2004 si è creata una terza figura, ovvero l’amministrazione di
sostegno e spesso, molteplici casi, che prima portavano all’inabilitazione, oggi generano la nomina
dell’amministratore di sostegno.
Al riguardo infatti l’art 418 C.C , stabilisce che nel corso del procedimento d’interdizione o
d’inabilitazione, se il Giudice ravvisa l’opportunità di non applicare tali provvedimenti bensì di
applicare l’amministrazione di sostegno, trasmette il fascicolo alla volontaria giurisdizione ovvero al
Giudice tutelare.
Tale istituto ha come fine quello di assicurare assistenza giuridica ad una persona che a causa di
menomazioni, psichiche o solo fisiche è nell’impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai
propri interessi .
Quindi, come ben evidente, in questo istituto NON è’ essenziale il concetto d’infermità mentale; il
presupposto è uno stato di incapacità, che può essere solo fisico ed anche solo temporaneo;
insomma è uno strumento operativo più flessibile e più leggero.
Si potrebbe sostenere, con linguaggio colorito, che l’interdetto e l’inabilitato sono “marchiati”,
mentre, l’Amministrazione di sostegno, non genera tale risultato; per contro, è bene subito annotare
che, il Cancelliere, annota in appositi e registri e deve comunicare allo Stato civile, i soggetti che siano
sottoposti a qualsivoglia delle tre procedura (interdizione, inabilitazione o amministrazione di
sostegno).
Il giudice tutelare provvede entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta alla
nomina dell’amministratore di sostegno, che deve giurare; lo stesso Giudice stabilisce l’oggetto
dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere, nonché gli atti che il
beneficiario può compiere con l’assistenza dello stesso amministratore.
Solitamente si parla di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma insisto, è uno strumento duttile
e pertanto possono crearsi “ordini” del Giudice , singolari e specifici , appositamente studiati per il
caso in esame.
A dimostrazione di una certa agilità si annoti che l’amministratore di sostegno può essere designato
dallo stesso interessato, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di
una futura eventuale propria incapacità.
Gli stessi atti compiuti dall’amministratore di sostegno, al di fuori dei limiti dell’incarico sono
anch’essi annullabili e così, ancora una volta, emerge l’elasticità di questo strumento giuridico.
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal momento in cui è cessata l’amministrazione
di sostegno.
E’ evidente che certi passaggi meriterebbero maggiore approfondimento e le norme sono molto più
circostanziate , ma in un visione generale la conclusione concisa potrebbe essere questa:
l’interdizione e l’inabilitazione sono istituti che evidenziano l’assoluta incapacità o comunque la
rilevante incapacità psichica del soggetto che ha bisogno dell’intervento di un Terzo ( Tutore o
Curatore ); mentre nella nomina dell’A.D.S rientrano situazioni molto diversificate tra loro, il
soggetto beneficiato non viene necessariamente “cancellato”, egli ha una maggiore autonomia e
mantiene una maggior dignità.
Sia ben chiaro che A.D.S può essere nominato un coniuge od un figlio, ma nulla vieta che, pur in
presenza del coniuge o di numerosi figli, sia nominato A.D.S. una terza persona (spesso un avvocato)
magari proprio per l’esistenza di dissidi tra i figli.
Daniela Cavallini:
Una precisazione: Tutore e Curatore sono figure assimilabili o differenti?
Avv. Massimo Minuti:
Il Tutore ed il Curatore sono figure assimilabili, ovvero lo spirito è l’intervento tecnico ed umano a
favore di un distinto soggetto; questo vale anche per il ruolo dell’ADS. Tuttavia, mi sento di attribuire
un maggior valore al ruolo del TUTORE , in quanto il taglio delle risposte ha come riferimento
soggetti che hanno un problema nel relazionarsi con altri, ma non scordiamo che la figura per
eccellenza del Tutore sorge nel momento in cui, un minore che pur non avendo nessun problema
fisico o psichico, rimane, purtroppo, privo dei genitori! Si potrebbe quindi dire che siamo di fronte a
TRE ruoli tecnici, che possono essere assunti da parenti, cosi come da Professionisti, sempre con il
passaggio della nomina del Tribunale; ma nel ruolo del Tutore deve emergere un forte senso di
responsabilità, al pari di un genitore, che, quindi, non si preoccupa dei soli atti giuridici, bensì della
crescita, della cultura e dell’evoluzione del soggetto.
Daniela Cavallini:
Poiché, come spesso accade, i dissidi familiari costituiscono la maggiore fonte dei problemi, com’é
consigliabile agire nei confronti dell’anziano – mediamente bisognoso di cure – sia esso con
disponibilità economiche o meno, ma ostinatamente ribelle (praticamente ingestibile) verso gli
stessi familiari – peraltro magari in lite fra loro – che dovrebbero prendersi cura di lui?
Avv. Massimo Minuti:
Schematizzo un caso, che mi ha visto coinvolto, così di fatto offro la risposta : madre vedova, con
salute critica e con testa “altalenante”, tre figli; due dei quali residenti a pochi chilometri d
costo e poi rivalersi sul terzo fratello; ambedue non solo dissentivano, ma trasmettevano l’idea che
con il loro contributo economico – riferisco pedissequamente l’unanime affermazione – “non si
sarebbe andati da nessuna parte”.
Preso atto della situazione, mi attivavo dunque per comprendere se l’immobile era appetibile sul
mercato; verificato che ciò era fattibile, coinvolgevo i tre figli, offrendo a ciascuno di Loro la
possibilità di acquistare l’immobile della madre ad un prezzo inferiore di 40 mila euro rispetto al
valore di mercato; la loro risposta era negativa!
Quindi l’immobile veniva messo sul mercato , la signora anziana ,che recalcitrava ad accettare la casa
di riposo, veniva seguita da una Psicologa per favorire il cambiamento e dopo 2 mesi entrava in Casa
di riposo; l‘immobile veniva compravenduto (ovviamente a tal scopo il Giudice offriva il suo
benestare ), il ricavo della compravendita da qualche tempo è giacente in Banca e serve per
integrare il costo della Casa di Riposo ( costo che viene pagato in parte con la pensione , in parte
con l’invalidità, ed il resto appunto con le somme di “serbatoio“ incassate).
Conclusione: la Signora è ben seguita e curata, i fratelli non litigano, due di loro vanno
regolarmente a trovare la madre . Credo mi siano tutti e tre grati.
In sostanza, ho fatto quello che semplicemente – con logica – avrebbero dovuto fare loro, ma
giammai avrebbero raggiunto lo stesso risultato, sia per conflitti di carattere, sia per mancanza di
decisione, sia per il timore di uno spostamento della madre.
Seguendo il caso spiegato , immaginiamo ora che la casa non fosse stata di proprietà e la pensione
della madre fosse stata modesta .
Il potenziale A.D.S si sarebbe dovuto rivolgere ai servizi Sociali, chiedere una partecipazione
economica ai figli e comunque agire per il ricovero in Struttura.
L’ingresso in Struttura non è certo agevole ; molto spesso allorquando l’ A.D.S. è un figlio, il servizio
di Assistenza Sociale, attua una sorta di passo indietro, lascia che i parenti si diano da fare ; di fatto la
situazione è più complicata .
La Struttura di solito per l’accoglimento “vincola “ il figlio ad integrare la retta ed il figlio, per ovvio
amore, si trova con il portafoglio nei guai; conseguentemente è molto più conveniente che A.D.S
non sia un parente.
Il perché è comprensibile dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22766 del 2016 la
quale ha sancito che: i famigliari degli anziani ricoverati presso le RSA, non sono tenuti al
pagamento della retta nel caso in cui l’anziano non sia in grado di pagarla, ma dovrà essere
corrisposta dall’ASL competente per territorio.
Quindi i contratti stipulati dai parenti dell’anziano con i quali gli stessi vengono vincolati al
pagamento della retta, possono essere dichiarati nulli!
Ed invece, a tutt’oggi, nella prassi, i parenti/figli sono “agganciati” e messi sotto pressione , partendo
dall’idea che Tutti farebbero qualsiasi cosa per una madre od un padre.
Attenzione però a non generalizzare , ovvero l’anziano che ha bisogno deve avere un reddito basso e
deve vivere da solo ; se invece è inserito e vive nel nucleo familiare di un figlio , chiaramente siamo in
una fattispecie diversa ove rileva la possibilità economica dell’intero nucleo.
In conclusione: se esistono possibilità economiche l’A.D.S è comunque colui che può essere utile
nella “gestione” oltreché nel superare certe situazioni familiari ; per inciso la Sua nomina libera i figli
dalla potenziale accusa di disinteresse; se invece sussiste una certa difficoltà economica l’A.D.S. è
colui che, agendo come cuscinetto, può intervenire con più forza verso le Strutture di assistenza,
senza essere monitorato o messo sotto pressione rispetto al suo portafoglio, cosa, che invece
accadrebbe se A.D.S. fosse un figlio.
Daniela Cavallini:
L’anziano “moderatamente problematico”, intendo affetto da una modesta forma di demenza
senile, può rifiutare l’ A.D.S. e/o le varie soluzioni sin qui esposte? Una sorta di “non voglio
nessuno lasciatemi in pace!”.
Avv. Massimo Minuti:
Inevitabilmente la risposta è articolata e deve essere esplicata caso per caso; in linea di massima con
una seppur iniziale demenza senile l’anziano non può opporsi e dovrà subire “piaccia o non
piaccia” quello che sarà meglio deciso per lui. Alla fine, nella vita, la logica offre le sue risposte
rigorose; si pensi ad una signora anziana seguita anche 24 ore su 24 da due badanti che si alternano
tra loro; se in ipotesi la Signora fosse allettata, dispiace per la Signora, ma il caso sarebbe più
controllabile, se invece la Signora è “stravagante e peperina”, basta un attimo per correre fuori di
casa od aprire il gas, mentre magari la badante è a comprare le medicine. In estrema sintesi, questa è
la mia modesta opinione: meglio un anziano in Casa di Riposo, ove i parenti vanno a trovarlo
ripetutamente, piuttosto che un figlio disposto a pagare due badanti, per non togliere l’anziano da
“casa” e poi, di fatto, si reca a trovare il genitore una volta a settimana come la “visita del dottore “.
Certo le strutture vanno scelte e controllate con cura, talune sono luogo di speculazione , ma siamo
Alle solite : un conto è ciò che è giusto, ben altra cosa l’esistenza di Strutture non all’altezza, che alla
base non dovrebbero avere le dovute autorizzazioni.